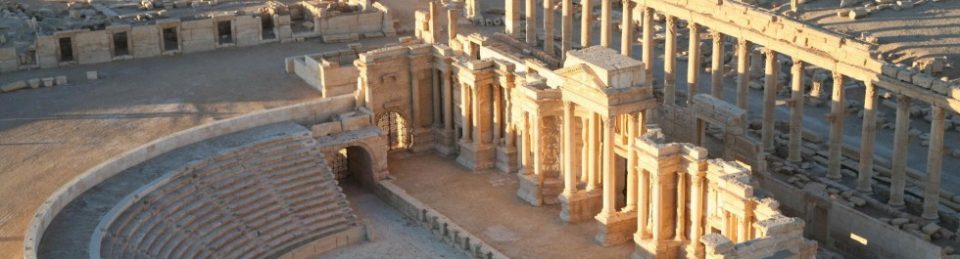Prima di procedere nella nostra sommaria lettura degli Atti e lasciarci alle spalle l’importante episodio del “concilio di Gerusalemme”, è obbligatorio che ci fermiamo un momento a contemplare e riflettere sul versetto 15, 28, che contiene a mio parere una delle sintesi più profonde e illuminanti della natura della Chiesa che si possano leggere in tutta la letteratura cristiana. Il “decreto apostolico” introduce l’elenco delle quattro prescrizioni deliberate per i convertiti dal paganesimo con questa straordinaria formula: «È parso bene allo Spirito Santo e a noi (ἔδοξεω γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν) di non imporvi altro peso al di fuori di queste cose necessarie (μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκας)».
In un versetto c’è tutto: la prima parte esprime nel modo più semplice e diretto il cuore dell’ecclesiologia, cioè della dottrina sulla Chiesa, che è il mistero della sua natura teandrica, cioè divinoumana; la seconda parte illustra concretamente il criterio fondamentale che deve ispirare il suo governo pastorale (e che deriva direttamente dalla coscienza di quel mistero, perché la pastorale dipende dalla teologia, e non viceversa, come troppo spesso si pensa oggi). “Lo Spirito Santo e noi” è una formula così audace che potrebbe sembrarci persino blasfema in quel suo accostare, mettendoli sullo stesso piano, la terza persona della Santissima Trinità e “gli apostoli e gli anziani di Gerusalemme”, cioè l’organismo collettivo che sta concretamente dietro a quel «noi». Ma è letteralmente vera: la Chiesa, che noi professiamo come contenuto della nostra fede cattolica («credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica»), è divina e umana. Non solo umana, perché crediamo che in essa opera continuamente lo Spirito Santo; non solo divina, perché l’azione dello Spirito si unisce, passa attraverso, si realizza per mezzo degli uomini – ma proprio per questo può essere frenata, ostacolata, fraintesa o deviata per causa loro. Chi nega, dimentica o sottovaluta l’una o l’altra componente della formula, si condanna a non comprendere nulla della Chiesa. Vista sotto questo profilo, la disinvolta baldanza dell’espressione usata qui da Luca (che ha un precedente, meno vistoso, in 5, 32), quel parlare dello Spirito Santo con tanta familiarità, come se fosse un socio della ditta, si rivela come segno di una profonda umiltà. Coloro che rivestono il ruolo di autorità ecclesiastica devono sentirsi, infatti, come i «vasi di creta» che portano il tesoro della straordinaria potenza di Dio di cui parla Paolo in 2 Cor 4, 7: nel loro agire coinvolgono la maestà divina, ma lo fanno con le capacità e i limiti di uomini, fallibili e peccatori come tutti.
Di qui la saggia autolimitazione nell’esercizio del potere di imporre e vietare, che viene dichiarata nella seconda parte del versetto: solo ciò che è necessario, nulla di più. Lo Spirito, di per se stesso, sarebbe come il vento che soffia dove vuole, senza limiti: quel «e noi», introduce tutto il limite che sempre connota l’orizzonte umano. La tentazione diabolica che insidia sempre e chiunque rivesta un’autorità nella chiesa, sia essa di tipo carismatico o istituzionale, è di abusarne facendosi “padrone della fede altrui”, come dice Paolo (2 Cor 1, 24). Una forma di questo abuso è la pretesa clericale di impicciarsi di tutto, e da questo punto di vista la formula impiegata nel decreto apostolico, «non imporre altro peso oltre le cose necessarie», è un esempio e un monito salutare. Potremmo dire che qui è la radice di quel motto, di incerta origine e non così antico come molti credono, che ha avuto molta fortuna nel mondo protestante, ma è stato felicemente recepito anche in ambito cattolico, da quando Giovanni XXIII nella sua enciclica Ad Petri cathedram scrisse che «semper retinendum probandumque est: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas».