La settimana scorsa ho seguito online il forte intervento con cui Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, parlando il 18 maggio all’assemblea dei centri culturali del movimento, ha ricentrato il senso e rilanciato le ragioni del lavoro culturale dei cristiani. Mi pare un discorso importante, che merita un’ampia riflessione comune nei prossimi mesi, non solo da parte dei membri dei centri culturali a cui si è direttamente rivolto, ma anche di tutti coloro che sono interessati alla ripresa di una presenza cristiana significativa nella nostra società. Oggi è stato pubblicato il testo, che si può leggere qui: https://it.clonline.org/news/cultura/2024/05/24/assemblea-associazione-centri-culturali-davide-prosperi. In attesa di compierne un’approfondita lettura, mi azzardo a condividere un paio di impressioni sulla base di quanto ho ascoltato, sperando che possano essere di qualche utilità anche ad altri.
Mi ha colpito innanzitutto la nettezza con cui Prosperi ha posto la questione della cultura al suo giusto livello, che è quello dell’esperienza della fede in quanto tale, non appena quello di una delle sue conseguenze. Il problema del lavoro culturale non consiste primariamente nella validità dei suoi contenuti e tanto meno nell’efficacia delle sue forme comunicative, ma è quello della fede di chi lo compie (cioè di tutti i cristiani, perché nessuno è esente dall’impegno di “rendere la fede cultura”, per dirla con le parole di Giovanni Paolo II). Ci siamo tante volte ripetuti che “il cristianesimo non è una dottrina, ma un’esperienza di vita che nasce da un incontro”, ed è una grande verità. Ma come tutte le affermazioni vere che l’uomo può fare, anch’essa ha bisogno di un’attenta sorveglianza e, per così dire, di una continua “manutenzione” al fine di mantenerla dentro la «verità tutta intera» (Gv 16, 13), altrimenti rischia di scivolare nell’equivoco, e diventare un’altra cosa. Esperienza, come don Giussani ci ha sempre insegnato e come Prosperi ha richiamato nel suo intervento, non è semplicemente “vivere la vita”, magari con intensità di energie, bontà di intenzioni e sentimento generoso: l’esperienza infatti implica sempre essenzialmente il giudizio;è tale solo in quanto è “vita giudicata”. E l’esperienza di fede, ben lungi dal ridursi a esperienza naturale (magari colorata di “sentimento cristiano”), è vita giudicata da Cristo. Vita vissuta con il criterio di Cristo che giudica ogni cosa: quando Paolo dice «noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1 Cor 2, 16) usa il termine nous, che vuol dire la mente, il modo di pensare, in definitiva la cultura di Cristo. È come un “pensiero dominante” che è sempre presente, si implica con tutto, tutto sfida, tutto discerne, tutto mette in crisi valorizzando quanto è a Lui amico (è il «Vagliate tutto e trattenete ciò che vale» di 1 Ts 5, 21). Ciò comporta anche un impegno dell’intelletto, uno sforzo conoscitivo, una sistemazione concettuale di cui non dobbiamo avere paura e che, soprattutto, non dobbiamo relegare in una nicchia per “specialisti”, come se fosse una cosa da intellettuali, perché spetta invece ad ogni cristiano, quale che sia il suo ruolo nella società e il suo livello di istruzione. Un grande storico dell’antichità, Paul Veyne, diceva che “ogni cristiano è un intellettuale” e aveva ragione, (se si intende bene ciò che voleva dire).
A questo proposito, c’è un passo degli Atti degli Apostoli che abbiamo già affrontato nella nostra lettura del libro (vedi qui: https://leonardolugaresi.wordpress.com/2024/01/09/per-diventare-cristiani-bisogna-anche-studiare-atti-degli-apostoli-27/) e che può essere utile richiamare: quello del battesimo dell’eunuco etiope da parte di Filippo (8, 26-38), che è il primo racconto di una conversione individuale che troviamo nel libro e ci fornisce in un certo senso l’archetipo di ogni storia di adesione alla fede cristiana. Lo Spirito Santo fa incontrare, sulla strada che porta a Gaza, il diacono Filippo con un uomo che viaggia in carrozza leggendo il profeta Isaia. È un personaggio ricco e potente, ma al tempo stesso una figura “marginale”: benché attratto dal giudaismo, non è un ebreo (non è dei nostri, diremmo noi), viene da un paese remoto e la sua condizione di eunuco ne fa un “diverso”, escluso secondo la mentalità corrente dalla possibilità di una piena appartenenza al popolo eletto (noi oggi potremmo forse paragonarlo a qualcuno con una condizione sessuale “problematica”). A quell’uomo Filippo rivolge una domanda formidabile: «Capisci ciò che leggi?». È la domanda che dovremmo farci anche noi, per noi stessi, tutti i giorni: “capisco ciò che leggo? E capisco veramente la realtà che mi circonda, mi assedia, si insinua ogni istante dentro di me?”. Ma è anche la domanda che dovremmo saper porre agli altri, con semplicità ma pure con totale franchezza (parresìa): “capisci ciò che leggi? O la distrazione, il pregiudizio ideologico, la conformità ottusa al pensiero unico te lo impediscono?”. Per grazia di Dio e merito della sua libertà, l’eunuco dà a quella domanda la più autentica e matura delle risposte: «E come potrei, se nessuno mi istruisce?». Che verità di posizione, che povertà di spirito in questa risposta! Allora Filippo monta sul carro e «prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù». Cioè gli spiega le cose, gli dà un insegnamento, gli fa il catechismo (quand’ero bambino io, si diceva “la dottrina”, perché si aveva meno paura delle parole cristiane). Cioè fa, precisamente, lavoro culturale. A quel punto l’eunuco, conquistato dall’annuncio di Cristo, prende lui stesso l’iniziativa: «Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?». In questo episodio paradigmatico si coglie bene un aspetto che dobbiamo avere molto chiaro, perché è un tratto distintivo del cristianesimo, una delle cose che nel mondo tardoantico faceva la differenza rispetto alla gran parte delle “proposte religiose” presenti nella società greco-romana di quel tempo, ma che vale anche oggi. Il cristianesimo non è semplicemente una prassi religiosa, un culto, cioè un certo modo di adempiere ai doveri nei riguardi del mondo divino, o un insieme di regole di vita individuale e comunitaria. Il cristianesimo è una notizia (una “buona novella”, appunto), e dunque c’è prima di tutto qualcosa da imparare e da capire e a cui dare il libero assenso della ragione, per diventare cristiani. Senza conoscere e comprendere ciò a cui si crede, non si può avere fede. Per questo nella Chiesa non si dà battesimo (degli adulti) senza una qualche forma di catechesi. E, va aggiunto, di una catechesi che sarà sì adeguata naturalmente alle capacità di ognuno, ma per nessuno potrà essere parziale, nel senso che venga insegnata solo una parte della Verità. No, la Chiesa insegna a tutti la «verità tutta intera». Non c’è esoterismo, nel cristianesimo, a differenza di tante altre forme religiose e filosofiche di allora e di oggi.
Un secondo spunto di riflessione che mi pare particolarmente meritevole di essere approfondito, tra i molti che Prosperi ha offerto, è quello che riguarda la tradizione, che del resto si lega strettamente a quanto ho appena detto . Ci siamo spesso richiamati, in questi anni, al fatto che il giudizio è una responsabilità personale che ciascuno deve esercitare nel paragone fra tutte le realtà che incontra nella propria esistenza quotidiana e il cuore; un paragone che verifica la corrispondenza di ogni fatto e di ogni proposta del mondo con quel complesso di evidenze ed esigenze originarie di cui ogni essere umano è strutturalmente dotato dalla natura. Anche questo è profondamente vero ma, di nuovo, ha bisogno di essere mantenuto nella verità tutta intera, per non venire a poco a poco risucchiato in una interpretazione soggettivistica, e in ultima analisi relativistica e sentimentale, che finirebbe per erigere “ciò che sento io, come lo sento io” a criterio ultimo del giudizio stesso. Sono due le chiavi che Giussani ci fornisce, per sfuggire alla prigione del soggettivismo: la prima è la consapevolezza che noi siamo opera di Dio che ci fa, siamo un dono: la corrispondenza con il cuore, dunque, è in ultima analisi un’ubbidienza alla volontà di Dio, un’adesione all’oggettività dell’impronta divina del nostro essere creati a sua immagine e somiglianza. Ma il secondo fattore oggettivo che costituisce il fondamento del giudizio è dato dalla storia, in cui Cristo avviene, e dalla tradizione di tale avvenimento, cioè dalla vita comunionale della Chiesa che, attraverso i secoli, lo porta fino a noi e ce lo rende presente e incontrabile. Dalla tradizione ci viene la proposta di un senso della realtà, come ipotesi da applicare e verificare nell’esperienza della vita. Nell’impostare il mio impegno con la realtà, parto sì dal presente, ma, come Giussani scrive nel Senso religioso, «per reagire ora devo usare una cosa che mi hanno dato nel passato: la mia carne, le mie ossa, la mia intelligenza, il mio cuore. Perciò la forza della costruzione futura è l’energia, la immaginatività, il coraggio del presente, ma la ricchezza del presente viene dal passato». È per questo che definisce «essenziale» l’impegno con la tradizione. Oggi anche nella Chiesa su questo c’è molta confusione: i due opposti fronti degli “innovatori” e dei “tradizionalisti” nel loro scontrarsi esprimono delle posizioni che, paradossalmente, si radicano nello stesso equivoco: entrambi, infatti, considerano la tradizione come un oggetto, un lascito del passato, e divergono solo nel modo di valutarlo. Ma la tradizione cristiana non è un oggetto, un reperto del passato, bensì una relazione vitale del presente con un “passato vivente”: l’incarnazione di Cristo è sì un fatto della storia, circoscritto nel tempo e nello spazio, ma Cristo è vivo, e con Lui è viva tutta la storia di coloro che per Lui sono vissuti nel corso dei venti secoli trascorsi. Un teologo ortodosso del XX secolo, Georgij Florovsky, ha una bellissima definizione di tradizione: la chiama «memoria carismatica della Chiesa». Trovo che sia molto appropriata in un duplice senso: «memoria carismatica» in quanto memoria dei carismi di cui è fatta la storia della Chiesa (che non è un’impresa umana, ma una vicenda in cui sull’agire dell’uomo lo Spirito agisce continuamente), e «memoria carismatica» in quanto ispirata da un carisma. Comprendere, amare e continuare la tradizione della Chiesa, svolgendone tutta la ricchezza, è infatti a sua volta un dono dello Spirito. La lealtà verso la tradizione e la capacità di valorizzarla in modo straordinariamente pertinente alle esigenze del mondo di oggi sono tratti caratterizzanti del carisma di don Giussani, di cui si avverte più che mai il bisogno nella Chiesa: a noi il compito, pur nella pochezza dei nostri mezzi, di metterli a frutto per il bene di tutti.
In tale prospettiva, mi sento particolarmente in consonanza e credo si debba valorizzare molto la parte dell’intervento di Prosperi in cui indica negli Atti degli Apostoli un testo di riferimento imprescindibile per aiutarci a comprendere adeguatamente l’unità delle diverse dimensioni del cristianesimo nella sua relazione missionaria con il mondo. Anche la lettura che ne stiamo facendo qui sul blog si basa sulla stessa chiave di lettura. (Vedi ad esempio qui: https://leonardolugaresi.wordpress.com/2024/03/16/e-finita-la-prima-parte-di-atti-facciamo-un-ripassino-veloce-atti-degli-apostoli-38/). La proseguiremo con maggiore impegno e consapevolezza, anche alla luce della messa a fuoco del 18 maggio.
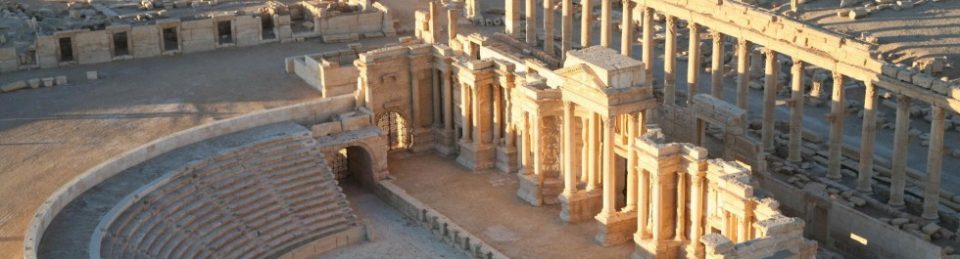
questa e’ la cultura cristiana :
https://lanuovabq.it/it/parigi-chartres-il-pellegrinaggio-che-attrae-i-giovani
sono queste le testimonianze valide , piu’ di ogni parola, quelle che un tempo ( tanto tempo fa) faceva CL e ora non fa piu’ .
"Mi piace""Mi piace"
https://www.iltimone.org/news-timone/francia-il-pellegrinaggio-di-chartres-fa-il-record-di-adesioni/
"Mi piace""Mi piace"
https://www.korazym.org/103189/voglio-vedere-dio-lomelia-del-cardinal-muller-al-termine-del-pellegrinaggio-di-pentecoste-a-chartres-i-fini-ultimi/
"Mi piace""Mi piace"
Dove e’ la cultura cristiana? E’ quella del Meeting di Rimini? E’ quella di tutti quelli che sono perfettamente integrati con la societa’ ?Persino un comunista, Cacciari, ha detto che se la Chiesa fosse segno di contraddizione i filosofi atei la troverebbero interessante.
Invece la Chiesa oggi non si oppone per nulla al penseto dominante.
Sale che ha perso il suo sapore, e’ degna solo di essere calpestata
"Mi piace""Mi piace"
Io consiglierei, intanto, di leggere il discorso di Prosperi.
"Mi piace""Mi piace"
Ho letto il discorso di Prosperi e l’ ho trovato pieno di pensieri belli e interessanti. Tuttavia secondo me aggira abilmente il problema principale che si pone oggi chi vuole fare parte della Chiesa cattolica. Posto che la tradizione e’ fondamentale , come dice Prosperi, certo non vista come un oggetto da venerare e mummificare,ma come una memoria attiva ,una relazione vivente col passato , una radice da cui trae linfa il presente,come si puo’ dialogare e magari adeguarci a chi tale tradizione nega e disconosce,a chi vuole tagliare le radici ?
Non parlo dei non credenti, o dei protestanti che negano la tradizione cattolica perche’ non ci credono, parlo dei cattolici che pero ‘ sono nel migliore dei casi indifferenti , oppure ripudiano e sono ostili alla tradizione e beffeggiano coloro che vorrebberlo essere fedeli come indietristi. Papa Francesco ha definito i cattolici tradizionalisti americani dei ” suicidi” . Ha deposto vescovi legati alla tradizione, ha revocato la concessione di Benedetto XVI di celebrare il latino secondo il vecchio rito, ha promosse le universita’ dei gesuiti dove si approva apertamente l’ ideologia LGBTW+ e l’ aborto.In Vaticano sono stati invitati a parlare esperti USA sul cambiamento climatico che sono apertamente abortisti.
Su tutti questi temi scottanti, su tutto questi temi attuali magari ci vorrebbe anche un ” giudizio comunitario” da parte un movimento radicato nella societa’ come CL, che pero’ appare sempre piu’ sbiadito .
Non prendere pubblicamente partito sulle divisioni della Chiesa al suo interno ,sui dibattiti, sui problemi sulle derive etiche mi sembra la decisione certo prudente ma poco entusiasmante per i giovani .
i semplici scout francesi con le loro bandiere , inginocchiati sulla strada al Pellegrinaggio di Chartres ci hanno fatto vedere cosa e’ una ” esperienza comunitaria ” della cultura cristiana viva e attuale e insieme legata alla tradizione . A Don Giussani sarebbero piaciuti.
"Mi piace""Mi piace"
Si può vedere l’incontro su youtube? Grazie Massimo Tonucci
"Mi piace""Mi piace"
Per ora credo di no. Penso che lei possa magari controllare, tra qualche giorno, se compare un link nel sito dell’Associazione dei centri culturali: https://centriculturali.org/ o su quello di Comunione e Liberazione.
"Mi piace""Mi piace"
Mi sembra che Prosperi abbia scoperto l’acqua calda. Fanno sorridere poi le citazioni di Papa Francesco, che sta lavorando con i suoi (vedi Zuppi) per allineare la Chiesa alle richieste del mondo.
"Mi piace""Mi piace"
Non sono d’accordo: le cose che Prosperi dice possono essere considerate “elementari”, nel senso che attengono ai fondamentali della fede cristiana, ma niente come le basi rischia di essere dimenticato o dato per scontato, specialmente oggi. “Back to the basics”, in questo senso, potrebbe essere anche un nostro motto 🙂
Quanto alle citazioni di papa Francesco, mi sembra più che corretto applicare anche in questo caso il criterio di 1 Ts 5, 21: «vagliate tutto e trattenete tò kalòn».
"Mi piace""Mi piace"
Va bene, torniamo alle basi, al cristianesimo bambino, non quello adulto di Prodi. Per quanto riguarda Francesco non c’è nulla da trattenere (molto poco) che non sia stato detto o scritto meglio dai predecessori immediati.
"Mi piace""Mi piace"