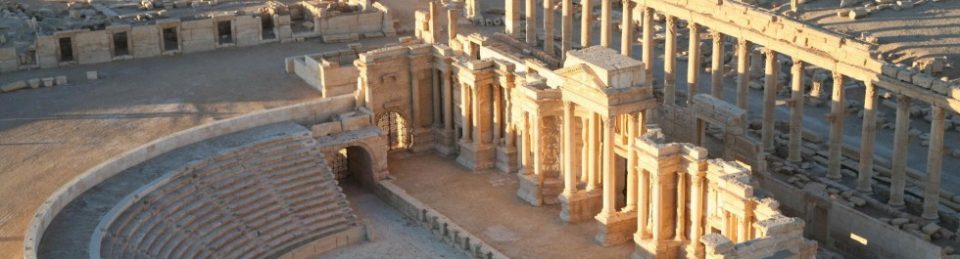Giacomo conclude il suo intervento esprimendo il giudizio (dice proprio κρίνω: non è un’opinione ma la formulazione di un giudizio autorevole) che non si debbano «tormentare quelli delle nazioni che si rivolgono a Dio» (15, 19) con troppe prescrizioni e divieti, ma limitarsi a chiedere loro quattro cose ben definite: «astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dall’immoralità, dalla carne soffocata e dal sangue» (15, 20). Dice anche che queste richieste vanno messe per iscritto (verba volant scripta manent è un motto che vale anche nella chiesa). La prudenza e il realismo di questo approccio vanno notati e lodati: da una parte il capo della comunità di Gerusalemme afferma che il primo criterio che la Chiesa deve seguire è quello di non rendere troppo difficile l’ingresso ai pagani che si convertono. La Chiesa esiste per portare gli uomini a Cristo: tutto ciò che è e che fa (o non fa) vale in funzione di tale scopo, e tutto nel suo agire va piegato a questa legge suprema: in questo Giacomo è animato dalla stessa tensione di Paolo quando scrive ai Corinti: «mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9, 22). Dall’altra però delle richieste imperative a chi entra vanno fatte, perché l’ingresso nella Chiesa non è l’aggiunta di un’esperienza in più alle altre che compongono il percorso esistenziale di un individuo, ma un vero e proprio cambio di status, anzi della stessa identità della persona: si cessa di appartenere ad un mondo e si comincia a far parte di un altro.
Di qui l’indicazione di soli quattro precetti essenziali, che vengono ripresi in un ordine diverso ma sostanzialmente uguali nel cosiddetto “decreto apostolico”, cioè nella lettera a nome degli «apostoli e degli anziani» di Gerusalemme diretta ai «fratelli venuti dalle nazioni in Antiochia, Siria e Cilicia» (15, 23) di cui vengono muniti i due «uomini influenti tra i fratelli» Giuda detto Barsabba e Sila, inviati nella metropoli siriana insieme a Baolo e Barnaba per comunicare ufficialmente alla seconda comunità della Chiesa di quel tempo le decisioni assunte a Gerusalemme. Si tratta di quattro norme rituali, sulla cui interpretazione c’è (come sempre) discussione tra gli studiosi, ma che ruotano tutte intorno all’imperativo fondamentale di troncare ogni possibile contatto con l’idolatria. Questo è il punto essenziale, su cui tutti i cristiani devono ritrovarsi senza possibilità di distinzione alcuna, quale che sia il loro retroterra culturale e religioso. La fede in Dio è incompatibile con l’idolo: qualunque idolo, in qualunque aspetto della vita. Pertanto, a mio avviso non si devono mettere in contrapposizione un’interpretazione ritualistica e una morale di tali precetti, i quali si riferiscono sì in prima istanza alle pratiche del culto pagano, ma stabiliscono un criterio di condotta che riguarda tutta la vita e che, sotto questo profilo, è valido anche per noi oggi.
Il primo obbligo è quello di «astenersi dalle contaminazioni degli idoli (τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων)» (15, 20) come dice Giacomo, ossia «dalle carni sacrificate agli idoli (ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων)» come sta scritto nella lettera (15, 29). Si tratta cioè di non consumare le carni degli animali sacrificati, che in gran parte non venivano bruciate sull’altare bensì messe in vendita al pubblico (e costituivano una voce non irrilevante dell’economia dei templi pagani), una scelta che comporta una rilevante presa di distanza culturale rispetto alle usanze comuni. Significa infatti porre pubblicamente un giudizio che discrimina dalla società, affermando la propria volontà di non avere nulla a che fare, nemmeno indirettamente, con il culto degli idoli. Una sorta di “obiezione di coscienza” che costituisce un forte marcatore di identità nel panorama variegato della città greco-romana. Paolo, a dire il vero, non era convinto che una misura del genere fosse strettamente necessaria: trattando del problema degli idolotiti in 1 Cor 8 e 10, 14-33 fa capire bene che, di per se stessa, quella carne si potrebbe anche mangiare, perché non è contaminata e non può contaminare, dato che gli idoli non sono nulla; però, in piena aderenza allo spirito del decreto apostolico, egli indica ai Corinti, come criterio supremo da seguire, quello dell’unità. Se mangiare quella carne può scandalizzare o confondere un fratello nella fede, allora bisogna rinunciarvi, perché sulla propria libertà spirituale deve assolutamente prevalere la carità nei confronti dei più deboli e la cura dell’unità della Chiesa.
La seconda astensione richiesta (nel discorso di Giacomo, mentre è l’ultima nel dettato della lettera) è quella dalla «immoralità sessuale (τῆς πορνείας)» e sembra a prima vista portarci su un altro terreno, ma in realtà rimane strettamente collegata al tema dell’idolatria per almeno tre aspetti: il primo è che porneia nella tradizione biblica è un concetto che è stato spesso applicato al culto degli dèi delle nazioni, considerato come una “fornicazione” che tradisce la fedeltà dovuta al vero Dio; il secondo è relativo alla “prostituzione sacra” che veniva praticata in certi templi e più in generale a riti orgiastici che potevano accompagnare certi culti; il terzo, infine, che riguarda in particolare noi, si riferisce al fatto che una certa esaltazione della dissolutezza sessuale oggi preponderante nel costume contemporaneo può ben essere considerata come una forma di idolatria. Paolo direbbe: «hanno come dio il loro ventre» (Fil 3, 17). Oggi l’astensione dalla porneia è (sarebbe) uno dei più forti marcatori di identità dei cristiani nel mondo.
Vengono poi gli obblighi, strettamente collegati, di astenersi «dal soffocato (τοῦ πνικτοῦ)» (15,20) cioè dalla carne non macellata secondo le norme rituali ebraiche che prescrivevano di dissanguarla, perché il sangue, sede della vita, appartiene solo a Dio e non può essere consumato dagli uomini, e di astenersi, appunto, «dal sangue (τοῦ αἵματος)» (15,20) che può sembrare una ripetizione del medesimo precetto, ma in realtà va inteso in un senso più ampio: rinunciare al sangue significa infatti anche rinunciare a versarlo, oltre che ad alimentarsene. Dunque non uccidere. Di nuovo vediamo come la prospettiva rituale delle norme di purità previste nel decreto si allarga naturalmente ad una visione integrale, in cui tutto si tiene e soprattutto si incardina sul dovere fondamentale della fedeltà a Dio che implica il rifiuto dell’idolatria.
Potremmo anche riassumere così il messaggio che il concilio di Gerusalemme manda ai pagani desiderosi di accostarsi alla fede in Gesù Cristo: venite senza paura, non c’è alcuna preclusione nei vostri confronti; ad una cosa però dovete, come tutti, rinunciare totalmente: gli idoli. Cominciava così per i cristiani non ebrei, il difficile impegno di vivere in mezzo a tutti gli altri, immersi in quella cultura pagana da cui loro stessi provenivano, preservando una purità non settaria che li differenziava ma non li allontanava dagli altri. Un crinale sottolissimo su cui stare, evitando di scivolare da una parte o dall’altro. Come gli altri, ma diversi perché senza idoli.
Ma noi, che dobbiamo vivere da cristiani in un mondo neopagano, di idoli ne abbiamo?